SPOLETO
Nucleo urbano originario, raccolto ai piedi della rocca trecentesca e caratterizzato da
vie strette, tortuose e spesso a gradinata, si affiancarono in età tardomedievale i
quartieri disposti sul piano alla sinistra del Tessino, mentre lo sviluppo edilizio
sull'altra sponda del torrente ebbe luogo solo in epoca recente, dopo la costruzione della
linea ferroviaria. Comune di 349,63 km2 con 37.881 ab.; industrie tessili,
metalmeccaniche, alimentari, grafico-editoriali, chimiche, calzaturiere, dei materiali da
costruzione, dell'abbigliamento e della fabbricazione dei fiammiferi. Turismo. Sede
vescovile. StoriaCentro degli Umbri, fortificato tra il sec. V e il IV a. C., dopo Sentino
(295 a. C.) fu costretta al dominio dei Romani che ne fecero una colonia (Spoletium).
Fedele alleata di Roma, lo fu soprattutto in occasione dello scontro con Annibale (217 a.
C.) che fu sconfitto proprio davanti alle mura di Spoleto. Municipio nel  90 a. C., ebbe dalla dipendenza romana esclusivamente dei benefici,
riconfermati nel basso Medioevo da Teodorico (493 d. C.) e da Belisario (536). Espugnata
da Totila (545) fu poi restaurata dal bizantino Narsete e dopo l'invasione longobarda
divenne sede di uno dei più vasti e importanti ducati d'Italia (v. sottolemma). Dopo la
lunga parentesi ducale, S. (e il suo territorio) fu considerata a livello di provincia
dello Stato Pontificio, governata da rappresentanti del potere centrale. Il capoluogo si
resse a comune e, come le altre città, conobbe le lotte tra le fazioni e tra i signori
locali, talvolta fomentate da sovrani esterni, come i Montefeltro, Gian Galeazzo Visconti
e Ladislao re di Napoli (sec. XV). Nei sec. XVII e XVIII S. perse ogni importanza.
Napoleone ne fece il capoluogo del dipartimento del Trasimeno (1809); il Congresso di
Vienna (1815) la restituì alla Chiesa, che la perse il 17 settembre 1860 con l'ingresso
delle truppe italiane. ArteDel periodo preromano restano tratti delle mura in opera
poligonale; di età romana sono le mura in opera quadrata che circondavano l'abitato e
l'arce. L'area del foro corrisponde all'attuale piazza del mercato; nella chiesa di S.
Ansano sono inglobati i resti di un tempio a fianco del quale è l'arco di Druso e
Germanico. Numerosi i resti di case romane con mosaici. All'estremità SW è il teatro
romano del sec. I d. C., mentre l'anfiteatro, del sec. II, si trova fuori delle mura,
presso il torrente Tessino. La basilica di S. Salvatore, notevole edificio paleocristiano
risalente ai sec. IV-V e più volte restaurato, conserva vari elementi originari, tra cui
il presbiterio con abside semicircolare; sull'interessante facciata d'impianto
classicheggiante si innestano originali motivi di probabile influsso orientale. La chiesa
di S. Pietro, eretta all'inizio del sec. V, ingrandita nel XIII, rifatta dopo un incendio
nel sec. XIV e ancora nel XVIII, ha la facciata decorata da bei bassorilievi duecenteschi.
I maggiori monumenti di S. risalgono tuttavia ai sec. XII-XIV, periodo di maggior
splendore della città, nel corso del quale essa venne acquisendo il severo aspetto che
ancora in larga parte mantiene. Il Duomo (sec. XII; aggiunte nel
sec. XV e rimaneggiamenti nel XVII) ha un'imponente facciata romanica, preceduta da un
portico rinascimentale e ornata da un mosaico bizantineggiante (1207). Nell'interno, in
larga parte barocco, si trovano notevoli affreschi absidali con Storie della Madonna,
dovuti a Filippo Lippi e aiuti (1467-69), affreschi e quadri del Pinturicchio, tele di A.
Carracci. Al sec. XII risalgono anche le romaniche chiese di S. Eufemia, S. Gregorio
Maggiore, S. Ponziano e l'interessante cripta di S. Isacco, con affreschi
90 a. C., ebbe dalla dipendenza romana esclusivamente dei benefici,
riconfermati nel basso Medioevo da Teodorico (493 d. C.) e da Belisario (536). Espugnata
da Totila (545) fu poi restaurata dal bizantino Narsete e dopo l'invasione longobarda
divenne sede di uno dei più vasti e importanti ducati d'Italia (v. sottolemma). Dopo la
lunga parentesi ducale, S. (e il suo territorio) fu considerata a livello di provincia
dello Stato Pontificio, governata da rappresentanti del potere centrale. Il capoluogo si
resse a comune e, come le altre città, conobbe le lotte tra le fazioni e tra i signori
locali, talvolta fomentate da sovrani esterni, come i Montefeltro, Gian Galeazzo Visconti
e Ladislao re di Napoli (sec. XV). Nei sec. XVII e XVIII S. perse ogni importanza.
Napoleone ne fece il capoluogo del dipartimento del Trasimeno (1809); il Congresso di
Vienna (1815) la restituì alla Chiesa, che la perse il 17 settembre 1860 con l'ingresso
delle truppe italiane. ArteDel periodo preromano restano tratti delle mura in opera
poligonale; di età romana sono le mura in opera quadrata che circondavano l'abitato e
l'arce. L'area del foro corrisponde all'attuale piazza del mercato; nella chiesa di S.
Ansano sono inglobati i resti di un tempio a fianco del quale è l'arco di Druso e
Germanico. Numerosi i resti di case romane con mosaici. All'estremità SW è il teatro
romano del sec. I d. C., mentre l'anfiteatro, del sec. II, si trova fuori delle mura,
presso il torrente Tessino. La basilica di S. Salvatore, notevole edificio paleocristiano
risalente ai sec. IV-V e più volte restaurato, conserva vari elementi originari, tra cui
il presbiterio con abside semicircolare; sull'interessante facciata d'impianto
classicheggiante si innestano originali motivi di probabile influsso orientale. La chiesa
di S. Pietro, eretta all'inizio del sec. V, ingrandita nel XIII, rifatta dopo un incendio
nel sec. XIV e ancora nel XVIII, ha la facciata decorata da bei bassorilievi duecenteschi.
I maggiori monumenti di S. risalgono tuttavia ai sec. XII-XIV, periodo di maggior
splendore della città, nel corso del quale essa venne acquisendo il severo aspetto che
ancora in larga parte mantiene. Il Duomo (sec. XII; aggiunte nel
sec. XV e rimaneggiamenti nel XVII) ha un'imponente facciata romanica, preceduta da un
portico rinascimentale e ornata da un mosaico bizantineggiante (1207). Nell'interno, in
larga parte barocco, si trovano notevoli affreschi absidali con Storie della Madonna,
dovuti a Filippo Lippi e aiuti (1467-69), affreschi e quadri del Pinturicchio, tele di A.
Carracci. Al sec. XII risalgono anche le romaniche chiese di S. Eufemia, S. Gregorio
Maggiore, S. Ponziano e l'interessante cripta di S. Isacco, con affreschi 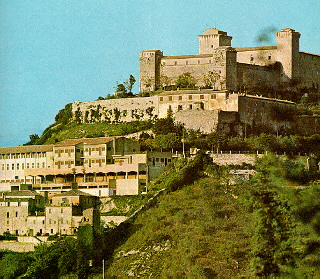 raffiguranti la Decapitazione del Battista, Gesù in gloria, l'Ultima Cena.
Le chiese di S. Domenico e S. Nicolò, gotiche, e il Palazzo Comunale risalgono al sec.
XIII; al successivo la poderosa Rocca e l'imponente Ponte delle Torri, a dieci arcate,
alto 80 m e lungo 230, che scavalca il torrente Tessino. Entrambe le opere sono attribuite
a M. Gattaponi. Meno significative le realizzazioni dei secoli seguenti, fra le quali può
ricordarsi il rinascimentale palazzo Arroni (sec. XVI), con facciata ornata di graffiti.
La pinacoteca comunale conserva opere di artisti umbri dal sec. XIII al sec. XVI e altri
dipinti di pittura italiana dei sec. XVII e XVIII. Musica: il Festival di SpoletoCittà
importante già in epoca romana, nel sec. XVI fu sede di rappresentazioni organizzate nei
palazzi. La vita musicale della città si imperniò per alcuni secoli (particolarmente dal
XVI) sulla cappella musicale del duomo, che ebbe tra i maestri che ne furono a capo V.
Sarti, F. S. Costanzi e A. Gargiulo. Alla metà del sec. XVII risale la costruzione del
primo teatro permanente, il Nobile, nato in legno, ricostruito in muratura nel 1880 e
ribattezzato Caio Melisso, e restaurato, dopo anni d'abbandono, nel 1958 per il primo Festival
dei Due Mondi. Questa istituzione, creata da Giancarlo Menotti e dedicata
alla musica, al teatro e al balletto, utilizza, oltre a questa sala e a vari luoghi
cittadini (compresa la piazza del Duomo), anche il Teatro Nuovo, inaugurato nel 1864 e
sede dal 1947 anche del Teatro Lirico Sperimentale. Il festival ha assunto subito rilievo
internazionale e ha presentato memorabili messinscene di opere liriche (specie di
Visconti), spettacoli di prosa d'avanguardia (Grotowski, il Café La Mama, l'Orlando
Furioso di Ronconi) e importanti compagnie di balletto (soprattutto i Ballets U.S.A. di
Robbins con molte prime assolute). Negli anni Ottanta il festival ha rinunciato in parte
all'impronta avanguardistica, in favore di una linea più tradizionalista.Ducato di
SpoletoSorto nei primi anni dell'invasione longobarda, fu affidato da Alboino a Faroaldo I
(ca. 571). Posto quasi al centro della penisola, il ducato fu l'anello di congiunzione tra
le terre longobarde del settentrione, dove risiedevano i re, e quelle del meridione (il
Ducato di Benevento); nello stesso tempo godette una notevole autonomia per la lontananza
del potere regio e le difficoltà delle comunicazioni, ostacolate dalla natura montuosa e
dai possedimenti bizantini che traversavano l'Italia dall'Adriatico al Tirreno. Inoltre il
suo sviluppo non incontrò valida resistenza nei territori confinanti perché l'autorità
legittima, quella bizantina, era molto debole e le piccole signorie che vi prosperavano
erano incapaci di collegarsi contro il comune nemico. La Chiesa, che esercitava una certa
supremazia, preferì, specialmente in principio, mantenere buoni rapporti con S. per
assicurarsi la via verso la Pentapoli e l'Esarcato. Già il secondo duca, Ariulfo (m.
600), aveva raggiunto la massima estensione territoriale allargando i confini a quasi
tutta l'Italia centr., dalla Pentapoli al Ducato di Benevento, e minacciando la stessa
Roma. Egli e i suoi successori trattarono con gli altri principi come sovrani
indipendenti, imponendosi con crescente autorità nelle lotte e nei maneggi dell'Italia
centro-meridionale. I re longobardi, preoccupati per tanta autonomia, tentarono spesso di
ricondurli a maggiore obbedienza revocando a sé, secondo un antico diritto, la loro
nomina e sostituendo gli indocili con i fedeli, ma con scarso successo. I duchi si
dimostraronogelosi della loro potenza e in un ambiente politico tanto fluido non mancarono
di alleati su cui contare, tra cui anche il papa, preoccupato di trovare un equilibrio in
un'Italia divisa tra i Longobardi e i Bizantini. Caso tipico fu il governo di Transamondo
II (720-742), più volte piegato da re Liutprando e più volte ribelle con il sostegno dei
pontefici, per i quali aveva parteggiato in occasione dell'iconoclastia. Alla fine,
abbandonato a se stesso, fu deposto e sostituito con Agiprando. Il duca Alboino giunse al
punto di giurare fedeltà al papa e al re dei Franchi, ma fu vinto da Desiderio (759) e
sostituito con Gisulfo. Anche per i papi tuttavia i duchi erano alleati scomodi e vicini
pericolosi; pertanto non si lasciavano sfuggire le occasioni per imporre la loro
supremazia o almeno per indebolirli. Quando Adriano I seppe della morte di Gisulfo nella
battaglia delle Chiuse tra Desiderio e Carlo Magno (773), nominò un duca a lui gradito.
La soggezione a Roma durò poco perché già nel 776 il ducato passò a Carlo Magno.
Allora iniziò un nuovo periodo con duchi di origine francese più legati al potere
centrale, sebbene non privi di una certa autonomia, della quale non mancò qualche abuso.
Quando l'impero carolingio si sfasciò (887), essi riacquistarono l'indipendenza di un
tempo e parteciparono alle competizioni per la corona d'Italia. Guido III fu il più forte
avversario di Berengario I. Sconfitto il re alla Trebbia, si fece proclamare re (889) e
incoronare imperatore dal papa Stefano V (891); l'anno seguente si associò al figlio
giovinetto Lamberto. Papa Formoso, dopo averlo assecondato, intimorito per la sua potenza,
chiamò in Italia il re di Germania Arnolfo, rinnovando le lotte. La morte di Guido (894)
e di Lamberto (898) indebolì S. e la sua fazione in Roma, prima tanto potente da
intromettersi e imporsi nelle elezioni dei papi. Sopravvennero tempi oscuri, di lotte e di
contese, complicate dalle invadenze degli imperatori germanici e della Chiesa, che con
Leone IX (1048-54) riesumò la donazione di Costantino per rivendicare a sé i diritti sul
territorio. L'una e gli altri si contesero la sovranità del ducato e a vicenda vi
nominarono i duchi; vi furono così anche duchi tedeschi. Federico Barbarossa, per punire
S. della sua resistenza, la incendiò (1155), poi concesse il ducato a Guelfo VI di
Baviera (1158). Nel 1198 Innocenzo III se ne impossessò e ottenne da Ottone IV la
rinuncia a ogni pretesa (Dichiarazione di Neuss, 1201). Nuove discordie indussero
l'imperatore a ritornare sulla sua decisione e a impadronirsene nuovamente (1210).
Gregorio IX ottenne da Federico II il definitivo riconoscimento della sovranità della
Chiesa su S. (1231) e il ducato fu soppresso nel 1247.
raffiguranti la Decapitazione del Battista, Gesù in gloria, l'Ultima Cena.
Le chiese di S. Domenico e S. Nicolò, gotiche, e il Palazzo Comunale risalgono al sec.
XIII; al successivo la poderosa Rocca e l'imponente Ponte delle Torri, a dieci arcate,
alto 80 m e lungo 230, che scavalca il torrente Tessino. Entrambe le opere sono attribuite
a M. Gattaponi. Meno significative le realizzazioni dei secoli seguenti, fra le quali può
ricordarsi il rinascimentale palazzo Arroni (sec. XVI), con facciata ornata di graffiti.
La pinacoteca comunale conserva opere di artisti umbri dal sec. XIII al sec. XVI e altri
dipinti di pittura italiana dei sec. XVII e XVIII. Musica: il Festival di SpoletoCittà
importante già in epoca romana, nel sec. XVI fu sede di rappresentazioni organizzate nei
palazzi. La vita musicale della città si imperniò per alcuni secoli (particolarmente dal
XVI) sulla cappella musicale del duomo, che ebbe tra i maestri che ne furono a capo V.
Sarti, F. S. Costanzi e A. Gargiulo. Alla metà del sec. XVII risale la costruzione del
primo teatro permanente, il Nobile, nato in legno, ricostruito in muratura nel 1880 e
ribattezzato Caio Melisso, e restaurato, dopo anni d'abbandono, nel 1958 per il primo Festival
dei Due Mondi. Questa istituzione, creata da Giancarlo Menotti e dedicata
alla musica, al teatro e al balletto, utilizza, oltre a questa sala e a vari luoghi
cittadini (compresa la piazza del Duomo), anche il Teatro Nuovo, inaugurato nel 1864 e
sede dal 1947 anche del Teatro Lirico Sperimentale. Il festival ha assunto subito rilievo
internazionale e ha presentato memorabili messinscene di opere liriche (specie di
Visconti), spettacoli di prosa d'avanguardia (Grotowski, il Café La Mama, l'Orlando
Furioso di Ronconi) e importanti compagnie di balletto (soprattutto i Ballets U.S.A. di
Robbins con molte prime assolute). Negli anni Ottanta il festival ha rinunciato in parte
all'impronta avanguardistica, in favore di una linea più tradizionalista.Ducato di
SpoletoSorto nei primi anni dell'invasione longobarda, fu affidato da Alboino a Faroaldo I
(ca. 571). Posto quasi al centro della penisola, il ducato fu l'anello di congiunzione tra
le terre longobarde del settentrione, dove risiedevano i re, e quelle del meridione (il
Ducato di Benevento); nello stesso tempo godette una notevole autonomia per la lontananza
del potere regio e le difficoltà delle comunicazioni, ostacolate dalla natura montuosa e
dai possedimenti bizantini che traversavano l'Italia dall'Adriatico al Tirreno. Inoltre il
suo sviluppo non incontrò valida resistenza nei territori confinanti perché l'autorità
legittima, quella bizantina, era molto debole e le piccole signorie che vi prosperavano
erano incapaci di collegarsi contro il comune nemico. La Chiesa, che esercitava una certa
supremazia, preferì, specialmente in principio, mantenere buoni rapporti con S. per
assicurarsi la via verso la Pentapoli e l'Esarcato. Già il secondo duca, Ariulfo (m.
600), aveva raggiunto la massima estensione territoriale allargando i confini a quasi
tutta l'Italia centr., dalla Pentapoli al Ducato di Benevento, e minacciando la stessa
Roma. Egli e i suoi successori trattarono con gli altri principi come sovrani
indipendenti, imponendosi con crescente autorità nelle lotte e nei maneggi dell'Italia
centro-meridionale. I re longobardi, preoccupati per tanta autonomia, tentarono spesso di
ricondurli a maggiore obbedienza revocando a sé, secondo un antico diritto, la loro
nomina e sostituendo gli indocili con i fedeli, ma con scarso successo. I duchi si
dimostraronogelosi della loro potenza e in un ambiente politico tanto fluido non mancarono
di alleati su cui contare, tra cui anche il papa, preoccupato di trovare un equilibrio in
un'Italia divisa tra i Longobardi e i Bizantini. Caso tipico fu il governo di Transamondo
II (720-742), più volte piegato da re Liutprando e più volte ribelle con il sostegno dei
pontefici, per i quali aveva parteggiato in occasione dell'iconoclastia. Alla fine,
abbandonato a se stesso, fu deposto e sostituito con Agiprando. Il duca Alboino giunse al
punto di giurare fedeltà al papa e al re dei Franchi, ma fu vinto da Desiderio (759) e
sostituito con Gisulfo. Anche per i papi tuttavia i duchi erano alleati scomodi e vicini
pericolosi; pertanto non si lasciavano sfuggire le occasioni per imporre la loro
supremazia o almeno per indebolirli. Quando Adriano I seppe della morte di Gisulfo nella
battaglia delle Chiuse tra Desiderio e Carlo Magno (773), nominò un duca a lui gradito.
La soggezione a Roma durò poco perché già nel 776 il ducato passò a Carlo Magno.
Allora iniziò un nuovo periodo con duchi di origine francese più legati al potere
centrale, sebbene non privi di una certa autonomia, della quale non mancò qualche abuso.
Quando l'impero carolingio si sfasciò (887), essi riacquistarono l'indipendenza di un
tempo e parteciparono alle competizioni per la corona d'Italia. Guido III fu il più forte
avversario di Berengario I. Sconfitto il re alla Trebbia, si fece proclamare re (889) e
incoronare imperatore dal papa Stefano V (891); l'anno seguente si associò al figlio
giovinetto Lamberto. Papa Formoso, dopo averlo assecondato, intimorito per la sua potenza,
chiamò in Italia il re di Germania Arnolfo, rinnovando le lotte. La morte di Guido (894)
e di Lamberto (898) indebolì S. e la sua fazione in Roma, prima tanto potente da
intromettersi e imporsi nelle elezioni dei papi. Sopravvennero tempi oscuri, di lotte e di
contese, complicate dalle invadenze degli imperatori germanici e della Chiesa, che con
Leone IX (1048-54) riesumò la donazione di Costantino per rivendicare a sé i diritti sul
territorio. L'una e gli altri si contesero la sovranità del ducato e a vicenda vi
nominarono i duchi; vi furono così anche duchi tedeschi. Federico Barbarossa, per punire
S. della sua resistenza, la incendiò (1155), poi concesse il ducato a Guelfo VI di
Baviera (1158). Nel 1198 Innocenzo III se ne impossessò e ottenne da Ottone IV la
rinuncia a ogni pretesa (Dichiarazione di Neuss, 1201). Nuove discordie indussero
l'imperatore a ritornare sulla sua decisione e a impadronirsene nuovamente (1210).
Gregorio IX ottenne da Federico II il definitivo riconoscimento della sovranità della
Chiesa su S. (1231) e il ducato fu soppresso nel 1247.
[pagina precedente]
 90 a. C., ebbe dalla dipendenza romana esclusivamente dei benefici,
riconfermati nel basso Medioevo da Teodorico (493 d. C.) e da Belisario (536). Espugnata
da Totila (545) fu poi restaurata dal bizantino Narsete e dopo l'invasione longobarda
divenne sede di uno dei più vasti e importanti ducati d'Italia (v. sottolemma). Dopo la
lunga parentesi ducale, S. (e il suo territorio) fu considerata a livello di provincia
dello Stato Pontificio, governata da rappresentanti del potere centrale. Il capoluogo si
resse a comune e, come le altre città, conobbe le lotte tra le fazioni e tra i signori
locali, talvolta fomentate da sovrani esterni, come i Montefeltro, Gian Galeazzo Visconti
e Ladislao re di Napoli (sec. XV). Nei sec. XVII e XVIII S. perse ogni importanza.
Napoleone ne fece il capoluogo del dipartimento del Trasimeno (1809); il Congresso di
Vienna (1815) la restituì alla Chiesa, che la perse il 17 settembre 1860 con l'ingresso
delle truppe italiane. ArteDel periodo preromano restano tratti delle mura in opera
poligonale; di età romana sono le mura in opera quadrata che circondavano l'abitato e
l'arce. L'area del foro corrisponde all'attuale piazza del mercato; nella chiesa di S.
Ansano sono inglobati i resti di un tempio a fianco del quale è l'arco di Druso e
Germanico. Numerosi i resti di case romane con mosaici. All'estremità SW è il teatro
romano del sec. I d. C., mentre l'anfiteatro, del sec. II, si trova fuori delle mura,
presso il torrente Tessino. La basilica di S. Salvatore, notevole edificio paleocristiano
risalente ai sec. IV-V e più volte restaurato, conserva vari elementi originari, tra cui
il presbiterio con abside semicircolare; sull'interessante facciata d'impianto
classicheggiante si innestano originali motivi di probabile influsso orientale. La chiesa
di S. Pietro, eretta all'inizio del sec. V, ingrandita nel XIII, rifatta dopo un incendio
nel sec. XIV e ancora nel XVIII, ha la facciata decorata da bei bassorilievi duecenteschi.
I maggiori monumenti di S. risalgono tuttavia ai sec. XII-XIV, periodo di maggior
splendore della città, nel corso del quale essa venne acquisendo il severo aspetto che
ancora in larga parte mantiene. Il Duomo (sec. XII; aggiunte nel
sec. XV e rimaneggiamenti nel XVII) ha un'imponente facciata romanica, preceduta da un
portico rinascimentale e ornata da un mosaico bizantineggiante (1207). Nell'interno, in
larga parte barocco, si trovano notevoli affreschi absidali con Storie della Madonna,
dovuti a Filippo Lippi e aiuti (1467-69), affreschi e quadri del Pinturicchio, tele di A.
Carracci. Al sec. XII risalgono anche le romaniche chiese di S. Eufemia, S. Gregorio
Maggiore, S. Ponziano e l'interessante cripta di S. Isacco, con affreschi
90 a. C., ebbe dalla dipendenza romana esclusivamente dei benefici,
riconfermati nel basso Medioevo da Teodorico (493 d. C.) e da Belisario (536). Espugnata
da Totila (545) fu poi restaurata dal bizantino Narsete e dopo l'invasione longobarda
divenne sede di uno dei più vasti e importanti ducati d'Italia (v. sottolemma). Dopo la
lunga parentesi ducale, S. (e il suo territorio) fu considerata a livello di provincia
dello Stato Pontificio, governata da rappresentanti del potere centrale. Il capoluogo si
resse a comune e, come le altre città, conobbe le lotte tra le fazioni e tra i signori
locali, talvolta fomentate da sovrani esterni, come i Montefeltro, Gian Galeazzo Visconti
e Ladislao re di Napoli (sec. XV). Nei sec. XVII e XVIII S. perse ogni importanza.
Napoleone ne fece il capoluogo del dipartimento del Trasimeno (1809); il Congresso di
Vienna (1815) la restituì alla Chiesa, che la perse il 17 settembre 1860 con l'ingresso
delle truppe italiane. ArteDel periodo preromano restano tratti delle mura in opera
poligonale; di età romana sono le mura in opera quadrata che circondavano l'abitato e
l'arce. L'area del foro corrisponde all'attuale piazza del mercato; nella chiesa di S.
Ansano sono inglobati i resti di un tempio a fianco del quale è l'arco di Druso e
Germanico. Numerosi i resti di case romane con mosaici. All'estremità SW è il teatro
romano del sec. I d. C., mentre l'anfiteatro, del sec. II, si trova fuori delle mura,
presso il torrente Tessino. La basilica di S. Salvatore, notevole edificio paleocristiano
risalente ai sec. IV-V e più volte restaurato, conserva vari elementi originari, tra cui
il presbiterio con abside semicircolare; sull'interessante facciata d'impianto
classicheggiante si innestano originali motivi di probabile influsso orientale. La chiesa
di S. Pietro, eretta all'inizio del sec. V, ingrandita nel XIII, rifatta dopo un incendio
nel sec. XIV e ancora nel XVIII, ha la facciata decorata da bei bassorilievi duecenteschi.
I maggiori monumenti di S. risalgono tuttavia ai sec. XII-XIV, periodo di maggior
splendore della città, nel corso del quale essa venne acquisendo il severo aspetto che
ancora in larga parte mantiene. Il Duomo (sec. XII; aggiunte nel
sec. XV e rimaneggiamenti nel XVII) ha un'imponente facciata romanica, preceduta da un
portico rinascimentale e ornata da un mosaico bizantineggiante (1207). Nell'interno, in
larga parte barocco, si trovano notevoli affreschi absidali con Storie della Madonna,
dovuti a Filippo Lippi e aiuti (1467-69), affreschi e quadri del Pinturicchio, tele di A.
Carracci. Al sec. XII risalgono anche le romaniche chiese di S. Eufemia, S. Gregorio
Maggiore, S. Ponziano e l'interessante cripta di S. Isacco, con affreschi 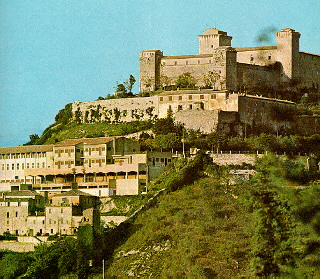 raffiguranti la Decapitazione del Battista, Gesù in gloria, l'Ultima Cena.
Le chiese di S. Domenico e S. Nicolò, gotiche, e il Palazzo Comunale risalgono al sec.
XIII; al successivo la poderosa Rocca e l'imponente Ponte delle Torri, a dieci arcate,
alto 80 m e lungo 230, che scavalca il torrente Tessino. Entrambe le opere sono attribuite
a M. Gattaponi. Meno significative le realizzazioni dei secoli seguenti, fra le quali può
ricordarsi il rinascimentale palazzo Arroni (sec. XVI), con facciata ornata di graffiti.
La pinacoteca comunale conserva opere di artisti umbri dal sec. XIII al sec. XVI e altri
dipinti di pittura italiana dei sec. XVII e XVIII. Musica: il Festival di SpoletoCittà
importante già in epoca romana, nel sec. XVI fu sede di rappresentazioni organizzate nei
palazzi. La vita musicale della città si imperniò per alcuni secoli (particolarmente dal
XVI) sulla cappella musicale del duomo, che ebbe tra i maestri che ne furono a capo V.
Sarti, F. S. Costanzi e A. Gargiulo. Alla metà del sec. XVII risale la costruzione del
primo teatro permanente, il Nobile, nato in legno, ricostruito in muratura nel 1880 e
ribattezzato Caio Melisso, e restaurato, dopo anni d'abbandono, nel 1958 per il primo Festival
dei Due Mondi. Questa istituzione, creata da Giancarlo Menotti e dedicata
alla musica, al teatro e al balletto, utilizza, oltre a questa sala e a vari luoghi
cittadini (compresa la piazza del Duomo), anche il Teatro Nuovo, inaugurato nel 1864 e
sede dal 1947 anche del Teatro Lirico Sperimentale. Il festival ha assunto subito rilievo
internazionale e ha presentato memorabili messinscene di opere liriche (specie di
Visconti), spettacoli di prosa d'avanguardia (Grotowski, il Café La Mama, l'Orlando
Furioso di Ronconi) e importanti compagnie di balletto (soprattutto i Ballets U.S.A. di
Robbins con molte prime assolute). Negli anni Ottanta il festival ha rinunciato in parte
all'impronta avanguardistica, in favore di una linea più tradizionalista.Ducato di
SpoletoSorto nei primi anni dell'invasione longobarda, fu affidato da Alboino a Faroaldo I
(ca. 571). Posto quasi al centro della penisola, il ducato fu l'anello di congiunzione tra
le terre longobarde del settentrione, dove risiedevano i re, e quelle del meridione (il
Ducato di Benevento); nello stesso tempo godette una notevole autonomia per la lontananza
del potere regio e le difficoltà delle comunicazioni, ostacolate dalla natura montuosa e
dai possedimenti bizantini che traversavano l'Italia dall'Adriatico al Tirreno. Inoltre il
suo sviluppo non incontrò valida resistenza nei territori confinanti perché l'autorità
legittima, quella bizantina, era molto debole e le piccole signorie che vi prosperavano
erano incapaci di collegarsi contro il comune nemico. La Chiesa, che esercitava una certa
supremazia, preferì, specialmente in principio, mantenere buoni rapporti con S. per
assicurarsi la via verso la Pentapoli e l'Esarcato. Già il secondo duca, Ariulfo (m.
600), aveva raggiunto la massima estensione territoriale allargando i confini a quasi
tutta l'Italia centr., dalla Pentapoli al Ducato di Benevento, e minacciando la stessa
Roma. Egli e i suoi successori trattarono con gli altri principi come sovrani
indipendenti, imponendosi con crescente autorità nelle lotte e nei maneggi dell'Italia
centro-meridionale. I re longobardi, preoccupati per tanta autonomia, tentarono spesso di
ricondurli a maggiore obbedienza revocando a sé, secondo un antico diritto, la loro
nomina e sostituendo gli indocili con i fedeli, ma con scarso successo. I duchi si
dimostraronogelosi della loro potenza e in un ambiente politico tanto fluido non mancarono
di alleati su cui contare, tra cui anche il papa, preoccupato di trovare un equilibrio in
un'Italia divisa tra i Longobardi e i Bizantini. Caso tipico fu il governo di Transamondo
II (720-742), più volte piegato da re Liutprando e più volte ribelle con il sostegno dei
pontefici, per i quali aveva parteggiato in occasione dell'iconoclastia. Alla fine,
abbandonato a se stesso, fu deposto e sostituito con Agiprando. Il duca Alboino giunse al
punto di giurare fedeltà al papa e al re dei Franchi, ma fu vinto da Desiderio (759) e
sostituito con Gisulfo. Anche per i papi tuttavia i duchi erano alleati scomodi e vicini
pericolosi; pertanto non si lasciavano sfuggire le occasioni per imporre la loro
supremazia o almeno per indebolirli. Quando Adriano I seppe della morte di Gisulfo nella
battaglia delle Chiuse tra Desiderio e Carlo Magno (773), nominò un duca a lui gradito.
La soggezione a Roma durò poco perché già nel 776 il ducato passò a Carlo Magno.
Allora iniziò un nuovo periodo con duchi di origine francese più legati al potere
centrale, sebbene non privi di una certa autonomia, della quale non mancò qualche abuso.
Quando l'impero carolingio si sfasciò (887), essi riacquistarono l'indipendenza di un
tempo e parteciparono alle competizioni per la corona d'Italia. Guido III fu il più forte
avversario di Berengario I. Sconfitto il re alla Trebbia, si fece proclamare re (889) e
incoronare imperatore dal papa Stefano V (891); l'anno seguente si associò al figlio
giovinetto Lamberto. Papa Formoso, dopo averlo assecondato, intimorito per la sua potenza,
chiamò in Italia il re di Germania Arnolfo, rinnovando le lotte. La morte di Guido (894)
e di Lamberto (898) indebolì S. e la sua fazione in Roma, prima tanto potente da
intromettersi e imporsi nelle elezioni dei papi. Sopravvennero tempi oscuri, di lotte e di
contese, complicate dalle invadenze degli imperatori germanici e della Chiesa, che con
Leone IX (1048-54) riesumò la donazione di Costantino per rivendicare a sé i diritti sul
territorio. L'una e gli altri si contesero la sovranità del ducato e a vicenda vi
nominarono i duchi; vi furono così anche duchi tedeschi. Federico Barbarossa, per punire
S. della sua resistenza, la incendiò (1155), poi concesse il ducato a Guelfo VI di
Baviera (1158). Nel 1198 Innocenzo III se ne impossessò e ottenne da Ottone IV la
rinuncia a ogni pretesa (Dichiarazione di Neuss, 1201). Nuove discordie indussero
l'imperatore a ritornare sulla sua decisione e a impadronirsene nuovamente (1210).
Gregorio IX ottenne da Federico II il definitivo riconoscimento della sovranità della
Chiesa su S. (1231) e il ducato fu soppresso nel 1247.
raffiguranti la Decapitazione del Battista, Gesù in gloria, l'Ultima Cena.
Le chiese di S. Domenico e S. Nicolò, gotiche, e il Palazzo Comunale risalgono al sec.
XIII; al successivo la poderosa Rocca e l'imponente Ponte delle Torri, a dieci arcate,
alto 80 m e lungo 230, che scavalca il torrente Tessino. Entrambe le opere sono attribuite
a M. Gattaponi. Meno significative le realizzazioni dei secoli seguenti, fra le quali può
ricordarsi il rinascimentale palazzo Arroni (sec. XVI), con facciata ornata di graffiti.
La pinacoteca comunale conserva opere di artisti umbri dal sec. XIII al sec. XVI e altri
dipinti di pittura italiana dei sec. XVII e XVIII. Musica: il Festival di SpoletoCittà
importante già in epoca romana, nel sec. XVI fu sede di rappresentazioni organizzate nei
palazzi. La vita musicale della città si imperniò per alcuni secoli (particolarmente dal
XVI) sulla cappella musicale del duomo, che ebbe tra i maestri che ne furono a capo V.
Sarti, F. S. Costanzi e A. Gargiulo. Alla metà del sec. XVII risale la costruzione del
primo teatro permanente, il Nobile, nato in legno, ricostruito in muratura nel 1880 e
ribattezzato Caio Melisso, e restaurato, dopo anni d'abbandono, nel 1958 per il primo Festival
dei Due Mondi. Questa istituzione, creata da Giancarlo Menotti e dedicata
alla musica, al teatro e al balletto, utilizza, oltre a questa sala e a vari luoghi
cittadini (compresa la piazza del Duomo), anche il Teatro Nuovo, inaugurato nel 1864 e
sede dal 1947 anche del Teatro Lirico Sperimentale. Il festival ha assunto subito rilievo
internazionale e ha presentato memorabili messinscene di opere liriche (specie di
Visconti), spettacoli di prosa d'avanguardia (Grotowski, il Café La Mama, l'Orlando
Furioso di Ronconi) e importanti compagnie di balletto (soprattutto i Ballets U.S.A. di
Robbins con molte prime assolute). Negli anni Ottanta il festival ha rinunciato in parte
all'impronta avanguardistica, in favore di una linea più tradizionalista.Ducato di
SpoletoSorto nei primi anni dell'invasione longobarda, fu affidato da Alboino a Faroaldo I
(ca. 571). Posto quasi al centro della penisola, il ducato fu l'anello di congiunzione tra
le terre longobarde del settentrione, dove risiedevano i re, e quelle del meridione (il
Ducato di Benevento); nello stesso tempo godette una notevole autonomia per la lontananza
del potere regio e le difficoltà delle comunicazioni, ostacolate dalla natura montuosa e
dai possedimenti bizantini che traversavano l'Italia dall'Adriatico al Tirreno. Inoltre il
suo sviluppo non incontrò valida resistenza nei territori confinanti perché l'autorità
legittima, quella bizantina, era molto debole e le piccole signorie che vi prosperavano
erano incapaci di collegarsi contro il comune nemico. La Chiesa, che esercitava una certa
supremazia, preferì, specialmente in principio, mantenere buoni rapporti con S. per
assicurarsi la via verso la Pentapoli e l'Esarcato. Già il secondo duca, Ariulfo (m.
600), aveva raggiunto la massima estensione territoriale allargando i confini a quasi
tutta l'Italia centr., dalla Pentapoli al Ducato di Benevento, e minacciando la stessa
Roma. Egli e i suoi successori trattarono con gli altri principi come sovrani
indipendenti, imponendosi con crescente autorità nelle lotte e nei maneggi dell'Italia
centro-meridionale. I re longobardi, preoccupati per tanta autonomia, tentarono spesso di
ricondurli a maggiore obbedienza revocando a sé, secondo un antico diritto, la loro
nomina e sostituendo gli indocili con i fedeli, ma con scarso successo. I duchi si
dimostraronogelosi della loro potenza e in un ambiente politico tanto fluido non mancarono
di alleati su cui contare, tra cui anche il papa, preoccupato di trovare un equilibrio in
un'Italia divisa tra i Longobardi e i Bizantini. Caso tipico fu il governo di Transamondo
II (720-742), più volte piegato da re Liutprando e più volte ribelle con il sostegno dei
pontefici, per i quali aveva parteggiato in occasione dell'iconoclastia. Alla fine,
abbandonato a se stesso, fu deposto e sostituito con Agiprando. Il duca Alboino giunse al
punto di giurare fedeltà al papa e al re dei Franchi, ma fu vinto da Desiderio (759) e
sostituito con Gisulfo. Anche per i papi tuttavia i duchi erano alleati scomodi e vicini
pericolosi; pertanto non si lasciavano sfuggire le occasioni per imporre la loro
supremazia o almeno per indebolirli. Quando Adriano I seppe della morte di Gisulfo nella
battaglia delle Chiuse tra Desiderio e Carlo Magno (773), nominò un duca a lui gradito.
La soggezione a Roma durò poco perché già nel 776 il ducato passò a Carlo Magno.
Allora iniziò un nuovo periodo con duchi di origine francese più legati al potere
centrale, sebbene non privi di una certa autonomia, della quale non mancò qualche abuso.
Quando l'impero carolingio si sfasciò (887), essi riacquistarono l'indipendenza di un
tempo e parteciparono alle competizioni per la corona d'Italia. Guido III fu il più forte
avversario di Berengario I. Sconfitto il re alla Trebbia, si fece proclamare re (889) e
incoronare imperatore dal papa Stefano V (891); l'anno seguente si associò al figlio
giovinetto Lamberto. Papa Formoso, dopo averlo assecondato, intimorito per la sua potenza,
chiamò in Italia il re di Germania Arnolfo, rinnovando le lotte. La morte di Guido (894)
e di Lamberto (898) indebolì S. e la sua fazione in Roma, prima tanto potente da
intromettersi e imporsi nelle elezioni dei papi. Sopravvennero tempi oscuri, di lotte e di
contese, complicate dalle invadenze degli imperatori germanici e della Chiesa, che con
Leone IX (1048-54) riesumò la donazione di Costantino per rivendicare a sé i diritti sul
territorio. L'una e gli altri si contesero la sovranità del ducato e a vicenda vi
nominarono i duchi; vi furono così anche duchi tedeschi. Federico Barbarossa, per punire
S. della sua resistenza, la incendiò (1155), poi concesse il ducato a Guelfo VI di
Baviera (1158). Nel 1198 Innocenzo III se ne impossessò e ottenne da Ottone IV la
rinuncia a ogni pretesa (Dichiarazione di Neuss, 1201). Nuove discordie indussero
l'imperatore a ritornare sulla sua decisione e a impadronirsene nuovamente (1210).
Gregorio IX ottenne da Federico II il definitivo riconoscimento della sovranità della
Chiesa su S. (1231) e il ducato fu soppresso nel 1247.